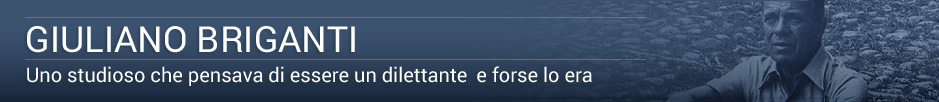
Barbara Briganti racconta suo padre
Giuliano e la figlia Barbara
Foto che Giuliano ha unito con dello spago - Archivio fotografico Barbara Briganti
Foto che Giuliano ha unito con dello spago - Archivio fotografico Barbara Briganti
Non ho idea di quando fu che Aldo e Clelia Briganti andarono ad abitare nell’appartamento al secondo piano di palazzo Ricci. Di sicuro vi erano già da tempo quando li conobbe mia madre nel 1942. Così come da molto tempo possedevano la casa del Ferrone, all’Impruneta. Per quanto ne so io, e i miei ricordi risalgono ai primi anni ’50, erano sempre stati li. Lui, lei, la decrepita - ai miei occhi - nonna Barbara e la Maria, cuoca e tutto fare, che agiva come, e in un certo senso era, la vera padrona di casa. Ci sono piccole foto di Giuliano adolescente su un terrazzo del palazzo, mentre gioca con un cane di razza indefinita, immagini che mi hanno sempre stupito, poiché né Aldo né Clelia sembravano avere il minimo interesse per gli animali, domestici e non.
Della decrepita nonna Barbara, piccina, minuta, baffuta e ornata di un imponente neo peloso sul viso, ricordo poco, comunque quel poco aveva come sfondo il Ferrone, dove a un certo punto doveva essere stata sistemata dal figlio e dalla nuora in compagnia di una donna di servizio, e dove fui mandata, all’età di cinque o sei anni insieme alla mia “tata”, per qualche settimana durante un’estate. Feci un’indigestione pantagruelica di tortelli con la marmellata e fui rispedita a casa immantinente con il marchio di bambina difficile.
Della casa di via Giulia ricordo di più. La strada stessa era un luogo affascinante e assolutamente diverso dalla Roma che mi era familiare. Abitavo allora in un quartiere borghese, che in quel tempo era silenzioso e sonnolento, e per contrasto, le strade che circondavano palazzo Ricci mi sembravano un mondo vivacissimo e pieno d’imprevisti. All’epoca c’erano artigiani o osterie in quasi ogni bottega, strade e vicoli erano invasi da mobili in restauro, biciclette, botti, scheletri di divani, copertoni, automobili, materassi e lana da cardare. E intorno a tutto ciò si agitava un popolo di omoni ruvidi e apparentemente poco amichevoli che mi facevano un po’ paura. Il palazzo, come tutti i palazzi aristocratici della Roma rinascimentale, era invece splendido e tetro, i muri scrostati, il cortile invaso da rampicanti inselvatichiti, le scale grandiose e molto belle ma buie e impregnate di odori di cipolla soffritta, polvere e muffa. C’era un portiere debitamente gallonato che si chiamava Serafino e che era molto gentile, e in mezzo ad un cortiletto una statua, il ritratto di una marchesa Ricci degli anni ’30 dell’Ottocento che trovavo bellissima. Era una scultura piuttosto grande in marmo, e rappresentava la dama seduta con un libricino in mano e lo sguardo perso nel vuoto. La parte più bella secondo me era la sua pettinatura, un trionfo di treccine, bandeaux e crocchia appuntita, complicatissimo e di un’eleganza straordinaria. Salutata la dama, si saliva per lo scalone, passando in riverente silenzio davanti alla porta del temibile professore al primo piano: non potevo sapere che quella era La Casa della Vita.
Via via che si saliva, lo scalone diventava più luminoso e al secondo piano c’era accanto alla porta d’ingresso della svampita e deliziosa marchesa Goldi Ricci, il grande portone di casa Briganti.
Si entrava in un piccolo ingresso molto luminoso e allegro (ed era la prima e l’ultima stanza allegra e luminosa di quella casa) dove erano radunate tutte le cose che mi piacevano: le stampe indiane con le principesse e i ferri da buoi romagnoli che suonano. Da un lato l’ingressino era stato suddiviso e dietro un tramezzo c’era la rastrelliera di legno dove venivano conservati i quadri di passaggio.
Poi iniziavano le stanze buie. Cavernose, con poche finestre e pareti coperte da armadi giganteschi, preziosi cassettoni ed enormi quadri scuri: mitologie, martirii, nudi contorti racchiusi in massicce cornici dorate (penso che in gran parte fossero quadri seicenteschi). Una conturbante Maddalena penitente che allora era attribuita a Cagnacci, Sebastiani trafitti altrettanto impressionanti. Ci si faceva strada tra un odore persistente di cera e di acquaragia mescolato con quello di biscotti appena sfornati proveniente dalla cucina.
Era una casa stranamente silenziosa, l’unico suono era quello del tintinnio delle mattonelle disgiunte del pavimento di cotto e quello del cristallino suono delle pendole, ce ne dovevano essere parecchie e sicuramente non erano sincronizzate perché una che suonava sempre da qualche parte.
La sfilata delle stanze buie terminava sul salotto che, affacciato sulla strada, riceveva finalmente luce. Lì era il Sancta Sanctorum, lì su due pareti intere erano conservati i libri, lì officiava Aldo, un tempo forse dalla scrivania che occupava il centro della stanza, quando lo conobbi io da una poltrona, in cui era perennemente sprofondato, con un sigaro e un libro in mano. Dietro la poltrona c’era un piccolo quadro che amavo molto e che rappresentava delle ninfe al bagno (Furini?), di fronte una specie di altare apparecchiato con una tovaglietta di lino sulla quale erano religiosamente sistemati i toscani, la forbicina curva per tagliarli in due, i fiammiferi (inglesi), l’accendino d’argento (inglese pure quello).
Il lato opposto della stanza era dominato da un enorme armadio anche questo pieno di libri. Era lì che si svolgeva il fulcro delle mie visite ai nonni. Dall’armadione venivano estratti i libri illustrati: Don Chisciotte della Mancia (sic) illustrato da Doré. Le Buffon di Rabier. le Mille e una Notte di Dulac , e con quelli mi tenevano buona per ore.
Sulla destra del salone c’era la sala da pranzo, buia come una cantina, con il tavolo perennemente apparecchiato per due persone in più di quelle comunque previste (usanze romagnole). Tovaglie stampate con disegni ruggine, apparecchiatura da gala con tutta l’argenteria e la cristalleria di casa (ricordo il terrore nel non sapere quali posate o bicchiere adoperare), il lume dal quale scendeva un brucia-incenso cinese a forma di scimmia che serviva per sostenere il filo del campanello, e la sputacchiera di ottone provocatoriamente sistemata in bella vista accanto alla sedia di Aldo. Credo che i pasti, abbondanti, lenti, noiosi, in cui si parlava prevalentemente di cibo o di lavoro, fossero un tormento non solo per me ma anche per Giuliano quando era presente. Dal mio posto usuale studiavo con angoscia le due nature morte di Baschenis che mi stavano di fronte (liuto, limoni, tappeto rosso) mentre Giuliano, che sedeva sull’altro lato del tavolo, forse si astraeva guardando il Pietro da Cortona che narrava un qualche episodio della Gerusalemme Liberata.
Dall’altra parte del salotto c’erano le stanze da letto, in quella dei nonni un enorme quadro che rappresentava un paio di scugnizzi intenti alla raccolta delle lumache (Cerquozzi?), un letto monumentale di ottone, cassettoni; in quella di Giuliano, quasi monacale, un lettino, una scrivania e un enorme cavalletto con sopra un quadro, ovviamente in posizione provvisoria. Ricordo che almeno in un’occasione si trattava di un sanguinoso episodio di decapitazione (Oloferne, Giovanni?). Spero che in quella stanza non ci dormisse davvero.
Ci doveva essere dell’altro in quella grande casa. Una camera per la nonna Barbara, che quando c’era stava sempre rintanata a cucire in uno stanzino minuscolo accanto alla cucina, una per la cuoca Maria, almeno un bagno e poi la cucina. E altrove, in un’altra parte del palazzo, il terrazzo con un pergolato di ferro sul quale sono state scattate molte fotografie, ma non ne ho nessun ricordo.
In quella casa prima e durante la guerra si riunivano gli amici di Giuliano. In quel salotto Aldo li faceva studiare foto e quadri, su quei libri si sono formati, in quel quartiere hanno dato vita ad una forma di resistenza, come racconta in un vecchio articolo del Messaggero Gino de Sanctis, alcuni di loro sono per questa causa poi morti, dalle finestre di quel salotto Giuliano guardava nel giugno del ’45 sfilare i soldati americani che risalivano via Giulia. E li ancora nei giorni febbrili che seguirono la liberazione, approfittando del fatto che Aldo e Clelia erano rimasti isolati sopra la Linea Gotica, si svolsero feste memorabili.
O almeno cosi narra la leggenda famigliare.
